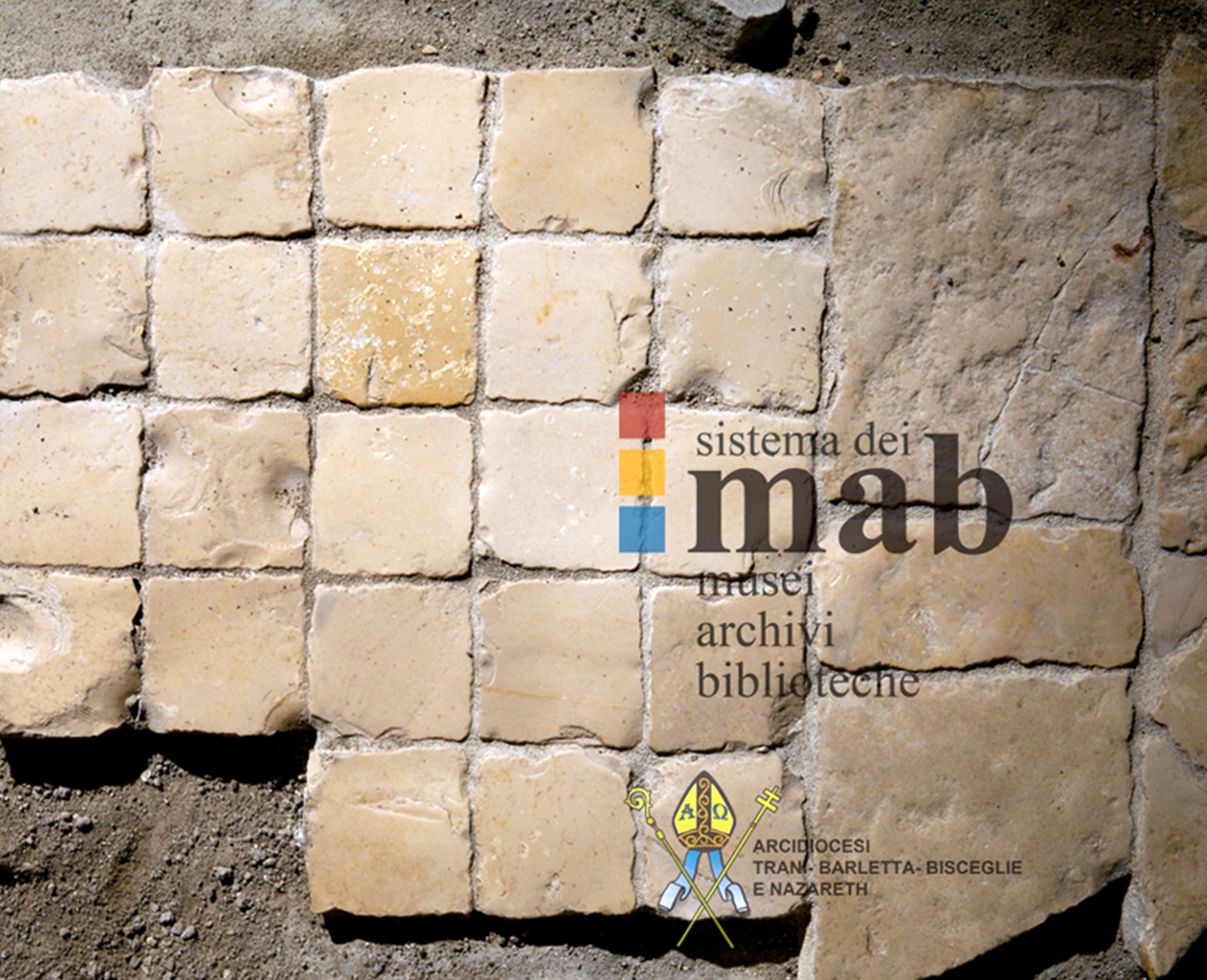Musei
Sezione di Barletta
Museo Cattedrale Barletta




Ricca di fascino e suggestione, la Cattedrale di Santa Maria Maggiore vanta preesistenze antichissime e una storia millenaria; infatti dagli scavi degli anni ‘90 del secolo scorso sono emerse tombe a grotticella, una fornace e una canaletta di scolo del periodo daunio, resti di una basilica paleocristiana(VI sec.) con un eccezionale pavimento musivo; ancora, sopraelevata di 50-60 cm i resti di una chiesa altomedievale (X-XI sec.). La Cattedrale, così come è possibile ammirarla oggi, rappresenta un elegante innesto di volumi riferibili sostanzialmente a due differenti epoche artistiche: romanica e gotica. Il primo stile identifica la parte della chiesa, riferibile alla seconda metà del XII sec. e si distingue per la facciata ricca di straordinari ornamenti scultorei tipici del romanico pugliese; le lesene e i tre ingressi (quelli laterali sono originari, quello centrale è stato rifatto in epoca rinascimentale) preannunciano la scansione interna con impianto longitudinale a tre navate divise da colonne di reimpiego con capitelli finemente lavorati, un finto matroneo che contribuisce a slanciare l’edificio e la copertura a capriate lignee. Appartengono ad una seconda fase di ampliamento della fabbrica avvenuta nel corso del XIII secolo la quinta e la sesta campata dove le colonne cedono il passo ai pilastri e le capriate lignee sono sostituite da volte a crociera. A questa fase di passaggio appartengono anche il campanile posto sul lato sinistro, il finestrone in facciata, il ciborio e il pulpito che richiamano nelle raffinate decorazioni la tradizione della Terrasanta, testimonianza tangibile del secolare scambio culturale tra la Puglia e l’Oriente. Il coro a cinque cappelle radiali di chiara ispirazione gotica costituisce il completamento della fabbrica iniziato nel XIV secolo in piena dominazione angioina e protrattosi per almeno due secoli: l’unione fra l’edificio più antico e l’ampliamento gotico avverrà infatti, tra il XVI e il XVII secolo. Del XV secolo sono le cappelle e la sacrestia che si sviluppano lungo la navata laterale destra, poi decorate e modificate nei secoli successivi. Le cappelle sono dedicate rispettivamente al Transito di S. Giuseppe e al Santissimo, la prima è stata decorata con splendidi marmi durante il XVIII sec. dai Cimafonte, la seconda è stata interamente affrescata dall’artista barlettano Raffaele Girondi (1873-1911). Da segnalare, inoltre, alcune tele di pregevole valore quali: sull’altare centrale del deambulatorio una tavola bifronte con la Vergine ed il Bambino da un lato e il Redentore dall’altro, che porta la firma di Paolo Serafini, modenese (seconda metà del sec. XIV); sulla controfacciata la tela con l’Assunzione della Madonna firmata Giuseppe Caiapano a. d. 1771; sul muro della navata destra una tela di Francesco De Mura (1696-1782) raffigurante l’Addolorata e sull’altare della famiglia Caggiano-Esperti la Presentazione di Maria al tempio di Nicola Menzele, datata 1775; sul muro della navata sinistra una pregevole tavola degli inizi del 1500 raffigurante Cristo alla colonna (immagine venerata nel nostro territorio come SS. Salvatore) e, più avanti, un Cristo fra S. Pietro e S. Lorenzo di Andrea Bordoni del 1596.
La consapevolezza di possedere uno dei fiori all’occhiello dell’architettura pugliese e il ricco patrimonio di tesori custoditi all’interno hanno indotto alla creazione di un museo del tesoro della cattedrale da non intendere come luogo a sé stante ma capace di comunicare con la struttura stessa perché sia le suppellettili sacre che la struttura chiesastica possano, insieme, raccontare la storia della nostra terra, dei nostri luoghi e padri.
Preesistenze daunio-romane
Datazione: III-I secolo a.C.
Materia/Tecnica: tufo, pietra calcarea, laterizi
Provenienza: scavi della cattedrale di santa Maria Maggiore.
Descrizione
A circa tre metri dall’attuale piano di calpestio della cattedrale, sono state individuate importanti emergenze archeologiche risalenti al periodo daunio-romano. Gli scavi effettuati tra il 1993 e il 1994, infatti, hanno messo in luce straordinarie scoperte che hanno anticipato di molti secoli la frequentazione del sito della Cattedrale ed in generale del borgo antico di Barletta. Scoperte che confermano una preesistente organizzazione del vicus preromano ben radicato nella zona castello-cattedrale. […]
Continua
La testimonianza più importante del periodo daunio-romano è costituita dal ritrovamento di quattro tombe a grotticella – di cui due più rilevanti ed una sola indagata – e di due strutture, una canaletta di scolo ed un impianto artigianale, che testimoniano un insediamento abitativo nella zona. I rinvenimenti funerari si concentrano nella zona delle fondazioni delle absidi romaniche, anche se dovevano estendersi per un’area di più vaste dimensioni, come testimoniano i dati rilevati durante un intervento del XIX secolo nella zona antistante la cattedrale. In corrispondenza dell’abside centrale e meridionale sono emerse due tombe a grotticella scavate direttamente nel banco calcarenitico-tufaceo, materiale relativamente tenero e facile da lavorare. La tomba indagata è quella posta in corrispondenza dell’abside centrale e ricalca la tipologia del vano frontale in asse con il dromos (discendente da Est a Ovest). L’ingresso alla tomba presenta stipiti e architrave scavati nella roccia e due lastroni in tufo come battenti, elementi realizzati con una certa precisione e regolarità che attestano soluzioni costruttive di un livello medio-alto. Destinato inizialmente ad un’unica famiglia, il vano indagato ha restituito tracce di più sepolture e corredi funerari collocabili tra il III e il I secolo a. C., evidente segnale di un riuso della tomba. Le altre due strutture funerarie individuate da tracce di dromoi, lungo il lato meridionale, sono state pesantemente manomesse dalle successive costruzioni. Nella zona della sesta campata è stato rinvenuto un sistema di canalizzazione con andamento nord-sud, che taglia trasversalmente il sottosuolo della Cattedrale, mentre tra la seconda e la terza campata è stato individuato un impianto artigianale di ridotte dimensioni scavato nella roccia, con stipiti in laterizio e tracce di bruciato. La presenza di un sistema di canalizzazione e di una struttura artigianale (forse una fornace) testimoniano l’utilizzo abitativo della zona vicino a strutture funerarie. Questa tipologia di insediamento, con presenza di «necropoli frammiste a unità abitative» è caratteristica dell’età arcaica e di molti abitati indigeni dauni che solitamente scompare tra il IV-III secolo a. C., quando un’organizzazione più complessa degli abitati sposta le necropoli ai margini della zona urbana e lungo le arterie viarie che partono dal centro abitato. Il passaggio ad insediamenti abitativi più complessi non avverrà in maniera repentina o in contemporanea per tutti i centri dauni (M. C. D’Ercole, Barletta in età preromana, 1990). Infatti, la datazione proposta per i corredi funerari (III-I a. C.) conferma la persistenza di pratiche funerarie indigene in un periodo in cui era avvenuta la romanizzazione nella Puglia centro-settentrionale. La presenza di queste emergenze archeologiche confermano l’ipotesi di un insediamento preromano a Barletta, già attestato in precedenza da contesti funerari in diverse zone della città, in particolare lungo la via per Canosa. Si tratta di un centro abitato legato alla presenza di un approdo portuale che all’epoca doveva dipendere dalla vicina e più importante Canusium e collegato comunque a tutti gli insediamenti presenti lungo la valle dell’Ofanto.
Corredi della tomba a camera
Autore /Ambito: ambito locale
Datazione:III-I secolo a.C.
Materia/Tecnica: ceramica, vernice nera, ferro, bronzo
Provenienza: scavi della Cattedrale di Santa Maria Maggiore
Continua
Delle quattro strutture funerarie del tipo a grotticella individuate nel corso dello scavo, solo quella nei pressi dell’abside centrale della Cattedrale romanica è stata indagata poiché conservata meglio rispetto alle altre. In seguito allo svuotamento della tomba, assieme alla terra di riempimento, sono stati rinvenuti resti riferibili a più inumazioni accompagnate da un vasto corredo funerario.
In particolare sono stati rinvenuti askoi, ollette, un numero cospicuo di unguentari, strigili di ferro, una fibuletta, coppe a vernice nera, lucerne e askos a vernice nera, uno specchio di bronzo, chiavi di ferro, una tazza biansata, una moneta, un ago di bronzo, una doppia situla, per un totale di settanta oggetti.
Gli askoi acromi sono riferibili al gruppo più antico databili quindi al III secolo a.C., più tardi (riferibili al III secolo avanzato), sono da inquadrare i due splendidi askoi a triplice collo di cui uno in particolare, caratterizzato da liste, motivi geometrici e vegetali e di un busto femminile di cui è maggiormente visibile il volto tondo. Databili al III-II secolo a.C. sono anche la doppia situla listata, gli unguentari, oggetti tipici di questo ambito cronologico, gli strigili di ferro (oggetto tipicamente maschile) e lo specchio (oggetto tipicamente femminile). Riferibili ai contesti funerari del II- I secolo a.C. sono, invece, le coppe a vernice nera, le ollette acrome e la lucerna a vernice nera.
Importante è il ritrovamento di una moneta della repubblica epirota che costituisce il terminus post quem per l’utilizzo delle sepolture. Dunque, dall’analisi di questo corredo funerario di epoche diverse emerge l’intensa frequentazione della tomba ma ciò ci aiuta a comprendere le trasformazioni sociali che hanno poi portato alla fase della romanizzazione.
Basilica paleocristiana
Autore: committenza di San Sabino, vescovo di Canosa dal 514 al 566
Datazione: primo quindicennio seconda metà VI secolo
Materia/Tecnica: mattoni in laterizio e conci in pietra
Misure: 28 x 16 cm (il rinvenuto)
Provenienza: scavi della Cattedrale di Santa Maria Maggiore.
Descrizione
La basilica rinvenuta nel sottosuolo della Cattedrale di Barletta rappresenta la testimonianza più antica di un edificio di culto cristiano eretto nell’area dove insiste il nucleo storico della città. Le strutture architettoniche superstiti si riferiscono a parte dei muri di fondo ad est […]
Continua
– con ampie tracce murarie dell’abside della navata centrale – e a gran parte della struttura muraria meridionale. Si sono conservati anche tratti dei muri di catena su cui poggiavano gli elementi verticali che scandivano la divisione in navate dell’edificio.
Da queste testimonianze si è potuto ricostruire l’impianto della basilica, mono-absidata, a tre navate divise probabilmente da pilastri, visto che le due basi lapidee ritrovate in situ non mostrano fori per i perni di fissaggio delle colonne; anche se va detto che le colonne della cattedrale romanica risultano sicuramente di spolio e si può, perciò, ipotizzare che siano state riutilizzate quelle della basilica paleocristiana. Il piano dell’edificio portato alla luce misura in lunghezza m. 27,84 e risulta scandito in otto campate, con un interasse di m. 2,20 di media. Poiché non è stato individuato né il muro nord (che sorgeva oltre il muro di fondazione della basilica romanica), né il muro ovest, sulla base delle indicazioni suggerite dalla struttura scoperta, si è ricostruita un’ampiezza di circa m. 20 e si è ipotizzata una lunghezza di circa m. 38, pari a dieci campate, forti anche delle similarità con la Basilica di Rufenzio ad Egnazia. Lungo il lato meridionale si individuano due soglie; quella più a ovest dava quasi certamente accesso all’esterno; quella più a est – da saggi di scavo condotti all’esterno della cattedrale romanica – introduceva in un complesso di ambienti, anch’essi con pavimentazione a mosaico. Quest’ultimo dato fa supporre una funzione liturgica (area battesimale?), o di rappresentanza (sede vescovile?), ma solo un ampliamento degli scavi verso la piazza potrà dare risposta a questo quesito. Una prima basilare indicazione per la datazione del complesso ci viene fornita dal ritrovamento di mattoni in cotto recanti il monogramma del vescovo Sabino, che resse la diocesi di Canosa all’incirca tra il 514 il 566, anno presumibile della sua morte. Questi mattoni sono stati rinvenuti sia presenti all’interno delle murature originarie, che riutilizzati nelle sostruzioni di epoca successiva che hanno distrutto il preesistente.
San Sabino si recò a Costantinopoli per missioni diplomatiche almeno due volte, la prima probabilmente nel 525 e la seconda nel 535. Risulta anche, dalla documentazione sia archivistica che archeologica, la sua intensa attività quale promotore di lavori edilizi nel territorio della sua diocesi. Anche i mattoni in cotto decorati a ruota raggiata e a margherita esapetala, rinvenuti negli scavi di Barletta, sono comuni alle costruzioni canosine di certa committenza sabiniana. Per un inquadramento circa l’influenza culturale nella quale si inseriscono le modalità costruttive della basilica barlettana ed anche per una più precisa datazione del complesso ci viene incontro sia l’analisi della divisione interna degli spazi che quella degli ampi resti della pavimentazione a mosaico. Questi ultimi presentano una decorazione esclusiva a motivi geometrici e schemi di composizione utilizzati in pieno VI secolo soprattutto in area ellenica ed altoadriatica. L’impianto basilicale longitudinale, a tre navate, con abside solo nella navata centrale, appare il più comune nel panorama architettonico paleocristiano dell’area apulo-lucana; l’edificio barlettano presenta, però, due elementi che lo caratterizzano ulteriormente. Tracce di murature all’interno della navata centrale – subito a ridosso dell’abside a nord e, sempre a nord, poco più avanti, all’altezza della quarta campata – consentono di ipotizzare un tipo di recinzione presbiterale definita a “pi greco” rovesciata, tipica dell’area greco-balcanica. Nella basilica barlettana tale recinzione presbiterale è ulteriormente suddivisa in un doppio ambiente, cosa che trova riscontro nella basilica di San Giusto presso Lucera e in quella sotto la Santissima Trinità di Venosa, indice di una versione architettonica propria di quest’area geografica. Un altro elemento spaziale interessante è l’ambiente che occupa lo spazio della navata meridionale in corrispondenza dell’abside, chiuso da una muratura e accessibile attraverso una soglia marmorea che si affaccia sul resto della navata sud. Si tratta di un elemento presente nelle costruzioni della Grecia continentale ed insulare, interpretato come “pastophorion” detto “di tipo elladico”, originario dell’Asia Minore e importato in Grecia non prima del secondo o terzo decennio del VI secolo.
Alla luce di queste osservazioni e tenendo presente anche il dato dei viaggi a Costantinopoli di San Sabino e la data della sua morte, il 566, è possibile stabilire che la basilica paleocristiana di Barletta è stata edificata nel primo quindicennio della seconda metà del VI secolo, su committenza di San Sabino, vescovo di Canosa, da maestranze che, inserendosi nel vivo della tradizione costruttiva dell’area apulo-lucana, hanno saputo inserire elementi originali provenienti dall’area greco-balcanica.
Luigi Nunzio Dibenedetto
Pavimentazione a mosaico
Autore: maestranze di influenza greco-balcanica
Datazione: metà VI secolo
Materia/Tecnica: pietre varie, cotto
Provenienza: scavi della Cattedrale di Santa Maria Maggiore
Descrizione
Dai frammenti rinvenuti della pavimentazione a mosaico si può giustamente ritenere che l’intera area della basilica paleocristiana di Barletta era rivestita da decorazioni musive. La parte più consistente di essi è stata ritrovata nella navata meridionale che risulta decorata da due pannelli musivi; il primo occupa una lunghezza di m. 12 e, partendo dal vano posto in fondo, ad est, nella stessa navata, si estende […]
Continua
fino alla settima campata; il secondo, di cui si è conservato un unico lacerto, doveva estendersi dalla settima campata fino alla parete di ingresso della basilica. Entrambi i pannelli presentano una cornice che corre tutt’intorno alla decorazione centrale: su una campitura di tessere bianche corrono una duplice serie di linee continue che incorniciano un motivo a treccia a due capi, con crocetta inscritta negli occhielli. La parte centrale della pavimentazione posta più ad est è occupata da una “composizione reticolata di esagoni tangenti per quattro angoli, formanti quadrati e stelle di quattro punte in colori contrastanti” secondo la definizione contenuta nel repertorio di Balmelle et alii, 1985, utilizzato da R. Giuliani nel suo studio “I mosaici del complesso paleocristiano di Barletta” pubblicato nel 2000. Questo schema compositivo è piuttosto raro, anche se attestato nella decorazione pavimentale, databile al VI secolo, di alcune case private a Rimini. La decorazione centrale della pavimentazione posta più ad ovest nella navata meridionale è formata da piccoli riquadri contenenti pelte contrapposte e cerchio in cui è inscritta una losanga a lati curvilinei. Il confronto più stringente è con il tappeto musivo della chiesa dell’Aghia Trias a Aighialousa nell’isola di Cipro, ma elementi simili si trovano anche nel San Leucio di Canosa. La decorazione pavimentale della navata centrale – che si conserva in due frammenti, attigui il primo alla sesta campata nord e l’altro alla settima campata sud – è sottolineata da una doppia cornice; quella esterna, più ampia, presenta un motivo a pseudo-meandro e quella interna, più stretta, uno ad onde correnti a giro incompleto. La cornice inquadra nel primo frammento un motivo a cerchi allacciati, all’interno dei quali si alternano circoletti e losanghe, nel secondo un disegno composto dall’alternanza di cerchi e quadrati. Confronti possono essere fatti con il complesso di San Giovanni a Canosa, la basilica A di San Giusto presso Lucera e la basilica di Rufenzio ad Egnazia. Del pavimento a mosaico della navata nord si conservano tracce solo della cornice, decorata da una treccia a calice. Altri frammenti riguardano la decorazione di sei intercolumni; del corridoio nord fra la recinzione presbiterale e gli intercolumni; dell’ambiente a est della navata meridionale interpretato come pastophorion; infine due piccoli frammenti con un motivo a squame sono quello che rimane del tappeto musivo del presbiterio. I frammenti della pavimentazione a mosaico della basilica paleocristiana sottostante la Cattedrale di Barletta ci forniscono chiare indicazioni sia sul fatto che l’intera area di calpestio era rivestita di un tappeto musivo, sia che i pannelli dello stesso sottolineavano con il loro differenziarsi la composizione degli spazi all’interno della basilica. I motivi geometrici disegnati dalle tessere su una campitura bianca, nei colori nero, grigio, giallo e rosso (con la presenza del rosa in un unico frammento) e il materiale delle stesse (pietre varie, ad eccezione di quelle rosse, ricavate da laterizi) inseriscono il pavimento barlettano nel quadro della produzione presente nell’area geografica apulo-lucana lungo il corso dei secoli V e VI, con una spiccata influenza di matrice adriatico-ellenica, in particolare delle produzioni egee del secolo VI.
Luigi Nunzio Dibenedetto
Chiesa altomedievale
Datazione: X-XI secolo
Materia/Tecnica: tasselli calcarei e laterizi stampigliati
Provenienza: scavi della Cattedrale di Santa Maria Maggiore
Descrizione
Nel corso dello scavo, in seguito alla rimozione di parte delle camere mortuarie di età moderna, in corrispondenza della navata settentrionale della Cattedrale si è rinvenuto un secondo allineamento costituito da una fila di pilastri quadrangolari e dal piano di calpestio costituito da laterizi e tasselli calcarei.
Questa struttura è stata rinvenuta a 1,80-2m circa rispetto all’attuale livello della Cattedrale. […]
Continua
I resti strutturali hanno portato gli studiosi ad avanzare l’ipotesi icnografica: sicuramente la chiesa altomedievale era costituita da un impianto longitudinale a tre navate, scandita da arcate rette da pilastri e conclusa da un’abside orientata. Questo secondo edificio sacro preesistente alla Cattedrale romanica era di dimensioni più ridotte rispetto alla basilica paleocristiana. Fondamentale per avanzare ipotesi di datazione è stato il recupero dei resti del piano di calpestio e di un frammento di affresco su un pilastro realizzato a fresco. I lacerti pavimentali in tasselli calcarei sono situati in prossimità di quella che doveva essere la zona absidale mentre le mattonelle in laterizio sono state rinvenute nella navata settentrionale. L’accostamento di due tipi pavimentali diversi potrebbe essere indice di eventuali rimaneggiamenti durante l’utilizzo della chiesa o potrebbe anche essere stata una volontà ben definita per creare una soluzione pavimentale particolare. I tasselli calcarei rientrano in una produzione regionale abbastanza diffusa e ampiamente documentata in Terra di Bari dove era in uso verso il X-XI secolo. Di particolare interesse artistico sono le formelle laterizie con decorazione stampigliata recante ognuna soggetti diversi (umani, animali, fantastici, geometrici e oggetti concreti) e di solito utilizzate come rivestimento parietale piuttosto che pavimentale. Inusuale è sia la tecnica di realizzazione di queste formelle con decorazione impressa sull’argilla ancora fresca mediante l’utilizzo di un timbro o tampone (tecnica utilizzata in area islamica o comunque di matrice bizantina) che riporta il soggetto da applicare sul laterizio; sia l’ipotesi che questo materiale potrebbe essere un reimpiego di materiale destinato ad altro utilizzo. Alla luce di questi elementi è stato possibile datare questa seconda emergenza sacra fra la seconda metà del X e la prima metà dell’XI secolo ma non è da escludere che la sua edificazione possa risalire anche alla fine del IX secolo; tuttavia sarebbe più plausibile la prima ipotesi visto che la cittadina barlettana si sviluppa maggiormente a partire dalla seconda metà del X e primi decenni dell’XI secolo. La chiesa altomedievale ha sicuramente svolto la sua funzione fino alla costruzione della Cattedrale romanica del XII secolo.
Camere Mortuarie
Datazione: varie epoche
Materia/Tecnica: tufo e pietra calcarea
Provenienza: scavi della Cattedrale di Santa Maria Maggiore
Descrizione
Lo scavo archeologico che ha interessato il sottosuolo della cattedrale di Barletta tra il 1993 e il 1994 ha messo in evidenza una serie di sepolture di diverse epoche. Dalla prima fase di scavo con l’immediata rimozione del pavimento della chiesa è emerso un complesso reticolo di camere mortuarie che occupavano per intero la navata centrale e parte della meridionale, mentre un solo vano è stato individuato nella navata settentrionale. […]
Continua
Le camere mortuarie erano ambienti rettangolari più o meno regolari, costruiti in tufo e pietra calcarea e voltati a botte; si poteva accedere agli ossari attraverso le botole ricavate nel pavimento e mediante lastre in pietra poste nelle pareti, a mo’ di gradini, per facilitare la discesa.
Probabilmente riferibili ad un unico momento costruttivo e poi riutilizzate nel corso dei secoli – e forse fino agli inizi del secolo scorso – le camere mortuarie hanno restituito un’ingente quantità di ossa che, insieme alla tracce di più tavolati lignei, hanno fatto ipotizzare la presenza di numerose inumazioni nello stesso ambiente.
Le camere mortuarie furono costruite anche con materiale di reimpiego ed è importante il ritrovamento di una lastra nell’apparato murario che riporta la data 1510; essa potrebbe essere indicativa circa il termine post quem per la costruzione delle camere che, in base ai rilievi archeologici, si fa risalire al XVI secolo.
Molto interessante anche il rinvenimento dei numerosi corredi funebri e reperti di abbigliamento come bottoni anche con tracce di tessuto, collane, monili, oggetti devozionali come croci, medagliette, corone di rosario e poi anche oggetti di uso quotidiano come battenti in bronzo, monete, aghi, chiodi ecc. che offrono un affascinante quadro di quelle che potevano essere le abitudini sociali e cultuali nella Barletta di età moderna.
Gli ossari hanno intercettato strutture precedenti alla costruzione della Cattedrale – come per esempio tracce del pavimento musivo paleocristiano e pilastri della chiesa altomedievale – e per questo si è proceduto alla rimozione delle coperture e di parte degli alzati per proseguire lo scavo e mettere in evidenza le importanti preesistenze archeologiche. Anche la zona absidale gotica della Cattedrale è stata indagata e sono emerse tracce di camere mortuarie più antiche, molte delle quali sono risultate svuotate dai resti di inumazioni e riutilizzate come butti di ceramiche invetriate e maioliche risalenti per la maggior parte al XVI e XVII secolo.
Nell’area delle navate laterali – oltre ad una serie di tombe assimilabili alla tipologia ad ossario – sono state rinvenute anche alcune sepolture monosome molto compromesse con un esiguo corredo funebre – oggetti metallici e monete – tanto che appare difficile collocarle in un periodo cronologico preciso: alcune di esse potrebbero risalire ad un’epoca bassomedievale, tra il XII e il XV secolo. Anche queste tombe sono realizzate con pietre calcaree o tufacee (rare) non rifinite come anche le lastre di copertura.
Sono state rinvenute tracce di queste sepolture anche all’esterno della chiesa, lungo il lato meridionale e nella zona della facciata. Nel corso dello scavo e della progressiva scoperta degli impianti altomedievale e paleocristiano sono emerse tracce di altre sepolture più o meno coeve alle chiese. Presenze di sepolture monosome con pareti composte da lastre calcaree appena sbozzate sono riferibili alla fase insediativa altomedievale che hanno intercettato a volte il pavimento musivo paleocristiano soprattutto lungo la navata sud della basilica paleocristiana. Rare ma degne di menzione sono alcune sepolture risalenti all’epoca paleocristiana e poste all’esterno della chiesa – nella zona absidale, lungo il lato meridionale e settentrionale – come un sepolcro con controfossa e scavato nella roccia che ha restituito una croce astile in ferro (VI-VII secolo), un sarcofago in tufo e una sepoltura infantile entro anfora.
Coevo a queste sepolture un sarcofago in pietra rinvenuto nella zona del deambulatorio della Cattedrale. Negli ambienti meridionali della chiesa paleocristiana sono state individuate tracce di tombe risalenti al VII secolo, testimonianze di un ridimensionamento delle funzioni liturgiche del complesso sacro forse legato ad un periodo di difficoltà della zona, dal momento che in questo periodo cominciano le incursioni longobarde nel territorio canosino.
Sono emerse, inoltre, tracce di sepolture all’interno dell’area sacra realizzate attraverso la rimozione di parte del pavimento e di alcune strutture murarie collocabili tra la fine del VII e gli inizi dell’VIII secolo.
Tali indizi fanno ipotizzare un utilizzo cimiteriale della basilica, pur non escludendo di fatto il perdurare di una sua funzione liturgica. In questo periodo di passaggio la chiesa paleocristiana anche con la sua prevalente funzione cimiteriale, continua a costituire un centro di attrazione per la popolazione del vicus. L’ultima e più antica fase sepolcrale si evidenzia nel periodo daunio-romano con le tombe a grotticella e i preziosi corredi funerari collocati per lo più nella zona delle fondazioni delle absidi romaniche.
Sarcofago paleocristiano

Autore /Ambito: adriatico orientale
Datazione: fine VI secolo
Materia/Tecnica: pietra calcarea scolpita
Misure: 212 x 70 x h. 55 cm (in media)
Provenienza: scavi della Cattedrale di Santa Maria Maggiore
Iscrizioni:
“Die X octob 1508 traslata fuit”
Descrizione
Nei saggi di scavo condotti nella zona del presbiterio, appena al di sotto della pavimentazione gotica del coro, è stato ritrovato un sarcofago in pietra; […]
Continua
la posizione del ritrovamento indica già una situazione di riutilizzo rispetto alla collocazione originaria.
La cassa, priva della lastra di copertura, ha una forma leggermente troncopiramidale, con i lati brevi inclinati a formare angoli acuti con il piano di fondo. Esternamente, lungo la base, su tre lati – la fronte e i due adiacenti – corre un listello orizzontale; sempre all’esterno sono ben visibili dei fori lungo la linea di terra, due sul retro del sarcofago e uno su un lato breve. Lungo uno dei lati brevi, a poca distanza dal listello, è posta un’epigrafe in caratteri capitali, capovolta rispetto al verso del sarcofago: Die X octob(ris) 1508 traslata fuit (fu trasferita il 10 ottobre 1508), chiaro indizio sia del riutilizzo della cassa, sia della sua posizionatura in senso rovesciato rispetto all’utilizzo originario.
Sulla fronte è scolpita, al centro, una croce latina a braccia espanse innestate su un disco posto all’incrocio dei bracci. Questo elemento decorativo, insieme con la zoccolatura, la forma e il materiale stesso in cui è scolpito il sarcofago (pietra calcarea), lo accomunano ad un gruppo di sarcofagi rinvenuti in Puglia, in particolare ai tre ritrovati in Cerignola, Aecae (Troia) e Trani, che vengono datati fra la fine del VI secolo e gli inizi del VII secolo e che presentano leggerissime varianti rispetto a quello barlettano.
Le caratteristiche di queste sepolture pugliesi trovano riscontro in ambito ravennate – in una serie di tombe datate alla fine del VI secolo – e in esemplari rinvenuti lungo l’Adriatico orientale; in particolare, dal punto di vista decorativo e formale, sono stati avanzati paragoni con frammenti scultorei provenienti dalle botteghe lapicide ubicate a Salona e nell’isola di Brazza, databili a partire dal V secolo. È molto probabile che dalla zona dalmata-istriana siano stati importati sia i sarcofagi ravennati, che quelli pugliesi, anche se nulla vieta di pensare che, ad esempio della produzione orientale, alcuni manufatti siano stati realizzati da lapicidi locali.
Luigi Nunzio Dibenedetto
Sezione di Barletta
Il Museo




Da sempre cuore pulsante del borgo antico è la Cattedrale di Santa Maria Maggiore il magnifico scenario, ricco di storia, arte, cultura e fede in cui si colloca l’esposizione del tesoro della cattedrale stessa e non solo.
Infatti il museo prevede tre livelli espositivi e il soccorpo. Al piano terra è possibile ammirare i preziosi paramenti liturgici, tra cui quelli appartenuti a papa Urbano VIII e papa Pio IX, al primo piano sono esposti gli argenti (calici, stauroteche, ostensori, l’urna eucaristica del Venerdì Santo, manufatti islamici) e la quadreria, al secondo piano le statue.
Gli oggetti provengono anche da altre chiese importanti della città come per esempio Santa Maria di Nazareth, per secoli sede arcivescovile della metropolia nazarena e la chiesa di San Cataldo.
La storia della sezione archeologica deve essere ricondotta agli inizi degli anni ’90 del ‘900 quando, durante i lavori di restauro della chiesa, vennero effettuati alcuni saggi di scavo con l’obiettivo di verificare le condizioni statiche delle strutture portanti dell’edificio. Così ebbe inizio lo scavo archeologico che ha portato alla luce secoli di storia e di frequentazione del sito. Quando furono terminati i lavori di scavo e restauro, in occasione della giornata di studi dedicata alla cattedrale di Barletta, fu lo stesso Mons. Michele Seccia, all’epoca Vicario Generale della Diocesi, ad affermare che “la Cattedrale, per quanto riaperta, è ancora e deve rimanere un cantiere, una officina della memoria, un cantiere di lavoro, di arte, di cultura, ma soprattutto di fede e religiosità perchè lo è nella sua essenza”. Fu quindi all’indomani della riapertura della chiesa che si pensò alla massima fruibilità del sito e dei suoi tesori “per non perdere la memoria e arricchire il futuro”( questo fu lo slogan che permise di tenere accesi i riflettori su questo importante gioiello della nostra città).
Con la stessa perseveranza hanno combattuto per anni i suoi successori fino a raggiungere l’obiettivo, ovvero l’apertura degli spazi musealizzati che non si pongono in maniera distaccata rispetto al contenitore ma vanno ad arricchire la storia della cattedrale che inevitabilmente si intreccia con altri luoghi, personaggi, culture.
Infatti l’allestimento è ispirato a un criterio di massima flessibilità espositiva e molti manufatti esposti sono ancora oggi utilizzabili e utilizzati.
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
Il Museo, per il suo modello gestionale è ritenuto un benchmark all’interno del panorama museale italiano e non solo. Rappresenta infatti, un’eccellenza sia dal punto di vista dell’offerta culturale che dal punto di vista gestionale.
Quali sono i vostri partner pubblici e che peso hanno nella vita del Museo?
Nel 2000 è avvenuto un passaggio importante: da ente pubblico il Museo si è trasformato in Fondazione di partecipazione, di diritto privato. La sua governance è costituita interamente da Istituzioni pubbliche (Ministeri dei Beni Culturali, dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università, Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano e le tre Università milanesi e da qualche anno anche la Camera di Commercio di Milano), ma la sua strategia di sviluppo, le sue modalità di lavoro e di relazione aprono alla partecipazione a diversi livelli di soggetti terzi.
La performance economica della Fondazione è di ricavi auto-generati pari al 75% del valore di bilancio. In pratica solo il 25% è rappresentato da fondi “certi” di tipo gestionale mentre i costi fissi superano il 50% del valore di bilancio. Questa proporzione e il valore assoluto dei contributi gestionali dai Partecipanti alla Fondazione non sono comparabili agli investimenti effettuati dalle istituzioni di altri Paesi europei su analoghi musei nazionali, di pari missione, superficie e patrimonio storico.
I fondi del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), che eroga gran parte della quota gestionale, sono rimasti gli stessi anche successivamente alla trasformazione in fondazione, e sono stati lievemente incrementati solo l’anno scorso.
Il Comune di Milano, proprietario dell’immobile in cui il Museo è ospitato, eroga fondi che di fatto vengono utilizzati per il funzionamento della struttura, che d’altronde richiede un’attenzione particolare essendo un edificio del 1500. Ci sono poi i contributi finalizzati e, in questo senso, durante questi anni il Comune di Milano ha investito sulla sistemazione dell’edificio mentre la Regione Lombardia ha sostenuto numerosi progetti e attività del Museo. Dal 2003 la Camera di Commercio eroga fondi per progetti e dal 2005 anche un contributo gestionale.
In cosa si contraddistingue il vostro Museo oggi, quali sono i suoi punti di forza?
Il Museo è il più grande museo tecnico-scientifico in Italia, uno dei 5 più importanti musei europei. È leader a livello internazionale per la metodologia dell’educazione informale alla scienza e alla tecnologia. È inoltre il più importante museo al mondo dedicato alla figura di Leonardo Da Vinci. Si distingue oggi nel panorama dei musei scientifico-tecnologici per la modalità di partnership con l’industria, che significa condivisione di obiettivi culturali e lavoro congiunto.
Questi traguardi e un grado di progettualità e di innovatività spinta costituiscono gli asset principali sui quali il Museo può far leva anche per lo sviluppo economico.
Qual è attualmente la vostra strategia di gestione?
L’attuale Direttore Fiorenzo Galli, che si è insediato nel 2001, a un anno dalla trasformazione in Fondazione, ha sviluppato una strategia che si sta rivelando determinante, visto che il budget di 4 milioni di euro del 2001 è arrivato ad oggi ad un valore di 12 milioni di euro: l’organizzazione ha internalizzato tutte le figure professionali necessarie per lo sviluppo di un Museo. A partire dai 36 dipendenti nel 2001 oggi annovera 116 dipendenti, assunti con contratti a tempo indeterminato, una vera rarità nel mondo culturale italiano.
Il Museo oggi si pone obiettivi ben precisi: innanzi tutto un completo rinnovamento sia dal punto di vista tematico, che dal punto di vista delle diverse modalità: nuove sezioni e laboratori interattivi dunque (telecomunicazioni, robotica, genetica e biotecnologie, nanotecnologie, alimentazione, materiali, energia, ecc.) realizzati secondo un nuovo modello museologico e museografico.
Il nostro obiettivo è quello di rinnovarci completamente e la strategia che mettiamo in atto si basa sul dialogo, la partecipazione e il coinvolgimento del mondo esterno, in cui gli stakeholders hanno la possibilità di condividere obiettivi specifici e partecipare ai progetti non solo in termini economici. D’altronde questo approccio era nell’identità della nostra istituzione in quanto già nei primi anni di vita del Museo il fondatore, l’industriale milanese Guido Ucelli di Nemi, con grande visione si impegnò per coinvolgere le istituzioni e le principali industrie della Lombardia.
La nostra attività di rinnovamento e di innovazione è divisa in progetti di diversa tipologia e dimensione. Ogni progetto persegue degli obiettivi specifici, ha budget dedicati predisposti grazie all’attività di fund raising presso partner pubblici e privati, che ritrovano nel progetto specifico un’opportunità per raggiungere i propri obiettivi.
Per noi il senso della partecipazione è proprio questo: fare in modo che il progetto in questione, già nella fase di ideazione, detenga delle caratteristiche che lo rendano interessante anche per soggetti terzi, che giungono alla decisione di finanziarlo.
Per rendere realizzabile un progetto è importante fare in modo che i due mondi, quello del Museo, con il suo staff e la sua identità, e quello dell’impresa e delle istituzioni in generale, si incontrino, dialoghino e costruiscano insieme. Da questo connubio nasce la collaborazione proficua che rende raggiungibili le mete che hanno un impatto sulla comunità e fanno la differenza.
Su quanti partner potete contare per ogni progetto?
Nel tempo i rapporti con il mondo esterno si sono evoluti. Inizialmente c’erano alcuni progetti sostenuti da Istituzioni pubbliche, altri da fondazioni, altri da aziende.
Oggi spesso si ha la convergenza di soggetti diversi sullo stesso progetto, che assume dimensioni più consistenti.
Un esempio in tal senso è la nuova area dedicata all’alimentazione, alla cui realizzazione hanno preso parte diversi attori, aumentando così il suo valore complessivo.
Qual è il range di investimento medio dei vostri sponsor o partner?
Dipende dalla dimensione del progetto: da programmi educativi che possono essere realizzati con 50 mila euro a interventi di progettazione e di realizzazione di esposizioni interattive che possono superare complessivamente il milione di euro. Di conseguenza cambierà l’investimento e il numero degli sponsor o dei partner.
In che modo valorizzate gli spazi del Museo per gli eventi corporate, ormai molto diffusi anche nel nostro Paese? Con quali vincoli e politiche commerciali?
Gli eventi corporate, l’affitto cioè di alcune sale del Museo per l’organizzazione di eventi aziendali, possono sembrare un’attività accessoria ma rientrano nella missione del Museo, essendo i professionisti delle aziende uno dei pubblici del Museo.
Pur avendo un approccio puramente commerciale, la nostra policy prevede durante un evento anche un’esperienza di natura culturale, come d esempio una visita guidata ad una sezione del Museo.
Dal punto di vista economico-finanziario questa attività rappresenta circa il 10% del budget annuale ma, dal mio punto di vista, crea soprattutto occasioni di relazioni permettendo di entrare in contatto con aziende ed enti, che potrebbero diventare sostenitori. Negli ultimi anni uno dei motivi più frequenti che hanno spinto le aziende a finanziare i nostri progetti è rappresentato dalla possibilità di coinvolgere i propri dipendenti e le loro famiglie in iniziative culturali ed educative di un’istituzione abituata ad “accogliere”.
Oltre agli incontri dettati da queste occasioni, come entrate in contatto con i vostri partner?
Dipende, a volte siamo noi ad avvicinarci, individuando i soggetti più adeguati sulla base delle caratteristiche del progetto in questione: tipologia, temi, target, ecc.
Quali sono i prossimi goal che vi proponete per quanto concerne il rapporto con i soggetti privati?
Un punto di miglioramento generale del Museo si avrà al termine del lungo e complesso processo di rinnovamento dell’edificio, a cura del Comune di Milano.
Qualche anno fa, ad esempio, abbiamo dedicato tempo ed energie per un’attività di fund raising del valore complessivo di circa 500 mila euro per la ristrutturazione dei servizi igienici del Museo, fondamentale per i nostri visitatori.
Infine, quali sono i tre suggerimenti che si sente di dare a coloro che oggi si occupano di marketing di un museo?
Innanzitutto il marketing, che è l’attività che permette al museo di dialogare con il mondo esterno e di includerlo nello sviluppo di attività culturali, è una professione che richiede precise competenze e capacità.
Bisogna conoscere il mercato delle risorse, utilizzare un metodo e un linguaggio adeguato.
In secondo luogo l’attività di marketing e fund raising non è fatta solo dall’ufficio preposto a tali attività ma da tutta l’organizzazione, che deve sviluppare una mentalità aperta al dialogo con l’esterno. La capacità di lavorare in partnership è un valore, fa parte della cultura della nostra organizzazione.
Io e il Direttore (Fiorenzo Galli, ndr) non incontriamo da soli i nostri potenziali finanziatori ma presentiamo l’organizzazione e le sue professionalità, chiamiamo a partecipare coloro che si occupano dei contenuti del progetto che proponiamo.
Molti nostri curatori si relazionano con entusiasmo con le aziende, dialogano con i loro esperti, visitano i centri di ricerca e gli archivi.
I nostri partner ci dicono che ragioniamo come un’azienda, ed in un certo senso è vero: siamo un’azienda il cui prodotto è di tipo culturale ed educativo, un servizio culturale per la collettività.
Museo svolge un’opera essenziale per comunicare e diffondere la memoria della storia e dei valori della Resistenza e della Deportazione, collegandola e mantenendola viva in raccordo con la perenne vicenda dei Diritti e delle Libertà fondamentali della persona.
Mette a disposizione della cittadinanza e particolarmente degli studenti delle scuole un allestimento permanente, ha organizzato trentacinque mostre temporanee, attività educative, rassegne cinematografiche, convegni, seminari, spettacoli. La collaborazione con le scuole è stata di particolare importanza e il Museo intende sviluppare e incrementare le sue iniziative di natura educativa.
Fedele alla sua missione e alla sua ragion d’essere, il Museo ha sempre agito tenendo strettamente legati la memoria e la documentazione di un passato tragico e glorioso e l’attenzione agli sviluppi problematici attuali dei diritti e delle libertà, in Italia, in Europa, nel Mondo.
Il Museo vive del contributo in servizi assicurato dal Comune di Torino, nonché delle quote annuali erogate in qualità di Soci fondatori dallo stesso Comune, dalla Provincia di Torino e dalla Regione Piemonte; ha potuto inoltre avvalersi del generoso sostegno delle Fondazioni di origine bancaria, in particolare della Compagnia di San Paolo.
Nell’attuale periodo di grave crisi, anche il Museo, come molte altre isitituzioni culturali, deve misurarsi con una diminuzione delle risorse e con la necessità di contenere al massimo le spese, anche a prezzo di una riduzione delle proprie attività.
Per questo chiediamo a tutti un contributo economico: un gesto che non sarebbe di sola generosità per una istituzione importante, ma anche di presa di posizione culturale.
I contributi possono essere inviati con bonifico bancario intestato a
Associazione Museo dei Diritti e della Libertà – Banca Prossima – IBAN IT80 Q033 5901 6001 0000 0019 375, con causale “Sostegno al Museo Diffuso”.
Grazie a tutti coloro che vorranno sostenerci.
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
Sezioni
Autore /Ambito: A. Argentiere messinese; B. Argentiere meridionale
Datazione: A. seconda metà XVIII secolo; B. fine XVIII – inizi XIX secolo
Materia/Tecnica: argento filigranato; cristallo
Misure: A. cm. 7.5×8.5; B. cm. 5×6
Provenienza: Cattedrale di Santa Maria Maggiore
Descrizione
Questi medaglioni reliquiario fanno parte di una ricca produzione eseguita dalle botteghe napoletane e siciliane nei secoli XVII e XVIII per ottemperare alle esigenze di una committenza devota, sia laica che ecclesiastica, che desiderava sottolineare l’importanza dell’oggetto di culto con la preziosità del suo contenitore. Vengono a sostituire gli imponenti reliquiari barocchi e consentono una diffusione maggiore del culto dei santi cui si riferiscono le reliquie. Infatti i nostri medaglioni possono aver costituito la parte terminale di un rosario, ma anche il decoro di una statua […]
Continua
(per esempio, già nello stesso museo della cattedrale di Barletta, sono usati medaglioni per racchiudere le reliquie sia sul busto argenteo di San Cataldo che sulla statua lignea di Sant’Orsola – v. schede dedicate). La mancanza del punzone si giustifica in questo tipo di manufatti per la difficoltà di apporlo ed è tipica degli argenti filigranati del ‘700; la restituzione ad una scuola piuttosto che ad un’altra va fatta esclusivamente in base alle caratteristiche stilistiche.
Il medaglione A. presenta una decorazione a volute acantiformi riccamente lavorate a filigrana, raccordate da una serie di sfere d’argento levigato; questa caratteristica formale avvicina l’oggetto alla produzione della città di Messina (vedi ad esempio il reliquiario a medaglione della chiesa di San Nicola a Palmi).
La cornice di argento filigranato che si svolge intorno all’ovale del medaglione B. presenta una decorazione a fili ritorti delicata e ariosa, che disegna ampi girali, arricchiti nell’incrocio da piccole infiorescenze. Il manufatto non presenta riferimenti stilistici forti né con la scuola siciliana, né con quella napoletana, ma si inserisce all’interno della produzione tardobarocca meridionale che nella seconda metà del XVIII secolo unisce le caratteristiche principali e la perizia tecnica di entrambe le scuole. I medaglioni sono tutti e due privi della reliquia originaria, ma la teca del medaglione B. porta ancora attaccato sul retro il sigillo in ceralacca rossa del vescovo responsabile dell’ispezione: si tratta con ogni probabilità di Mons. Bartolomeo De Cesare, vescovo di Potenza dal 26 giugno 1805 al 30 settembre 1819 il cui stemma è riprodotto sulla ceralacca: “d’azzurro al pino sinistrato da un leone rampante sul tronco, il tutto d’oro”. Mons. De Cesare va ricordato per aver riaperto il Seminario, ma anche per essere stato il primo vescovo delle diocesi unite nel 1818 di Marsico e Potenza, nell’ambito del riordino delle diocesi del Sud, in applicazione del Concordato tra Santa Sede e Regno di Napoli. Sotto il suo episcopato la città di Potenza fu elevata a capoluogo della Basilicata. Di lui possediamo anche le: “Omelie sacre sulla cognizione di Dio uno, e trino”, dirette specialmente al clero, ed al popolo della sua diocesi e date alla luce nella stamperia di Potenza nel 1809. Il suo nome è legato soprattutto all’inizio del culto di Santa Filomena che ebbe origine il 25 maggio 1802 con la ricognizione dei resti mortali nel cimitero di Priscilla. In conseguenza di questo evento, poco dopo la sua elezione a vescovo di Potenza, Mons. De Cesare accompagnò a Roma e sostenne nella sua richiesta il sacerdote nolano Francesco De Lucia; questi chiese in dono il corpo di Santa Filomena a Mons. Ponzetti, custode delle reliquie; avendo ottenuto il consenso, le reliquie furono trasportate prima a Napoli e poi a Mugnano del Cardinale nella chiesa dedicata alla Madonna delle Grazie. Un’altra notizia interessante per noi è che a distanza di quasi un secolo, dal 1900 al 1913, resse la diocesi di Potenza il nostro concittadino Mons. Ignazio Monterisi, che, come scrive don Gerardo Messina in “La Diocesi di Potenza – Cenni storici”, fu: “vescovo di forte tempra e lungimirante, che promosse un rinnovamento degli studi per il clero, chiuse l’ormai asfittico seminario locale ed inviò i suoi chierici a studiare nelle facoltà teologiche romane, orientò l’impegno dei laici cattolici nella politica, sostenne la stampa cattolica ed operò per la purificazione della religiosità popolare e la riforma del clero”. È del tutto lecito ipotizzare che possa essere stato Mons. Ignazio Monterisi a donare alla Cattedrale di Barletta il medaglione col sigillo del suo predecessore, Mons. De Cesare, contenente, molto probabilmente, una reliquia di Santa Filomena. Luigi Nunzio Dibenedetto


Descrizione
Autore /Ambito: Manifattura islamica
Datazione: XII-XIII secolo
Materia/Tecnica: Bronzo a fusione e lavorato a traforo; aggiunte in ferro
Misure: 10×41 cm; in sospensione 120 cm
Iscrizioni:
“Gloria, felicità perfetta, generosità piena, alta gioia perpetua, benessere completo [al possessore]”.
Provenienza: Cattedrale di Santa Maria Maggiore.
Descrizione:
Splendido esempio di manifattura islamica, lo scrigno del tesoro della cattedrale di Barletta è un cofanetto in bronzo, più precisamente in oricalco, una particolare lega di bronzo e stagno con tracce di zinco, che conferisce all’oggetto la caratteristica colorazione dorata. Di forma circolare, è sollevato da quattro piedini globulari uniti allo scrigno attraverso borchie traforate. Sul coperchio altre sei borchie sovrapposte, sempre lavorate a traforo, di cui due fungono da ganci di chiusura, due nascondono le cerniere che lo uniscono alla base. Gli elementi decorativi più interessanti si concentrano sul coperchio dove si trova al centro un piccolo gancio inserito in una corona baccellata, cui seguono due fasce concentriche che contengono un’iscrizione con due canoni calligrafici differenti: in caratteri cufici nella parte più interna, in caratteri naskhi in quella più esterna. Il primo stile, originario della città irachena di Kufa, presenta un andamento angolare e severo, mentre il secondo, più antico, appare morbido e arrotondato. L’iscrizione è una frase augurale: ‹‹Gloria, felicità perfetta, generosità piena, alta gioia perpetua, benessere completo [al possessore]›› che ci fa supporre un’originaria destinazione privata dell’oggetto. Questa tipologia di iscrizione si ritrova anche in molti cofanetti in avorio realizzati da maestranze arabe attivi nella Sicilia normanna del XII secolo. L’uso della scrittura – che concentra nella parola la massima espressione del divino – è una caratteristica tipica della tradizione araba ed è uno dei filoni decorativi principali dell’arte islamica, insieme all’ornato geometrico e all’arabesco. Oggetto inconsueto nella forma, raffinato e lineare nella decorazione, esso ricorda un simile scrigno conservato nel duomo campano di Caiazzo, opera di manifattura egiziana del XII secolo, ambito che alcuni ipotizzano anche per il nostro scrigno. Anche per quanto riguarda la datazione si ritiene plausibile collocare il manufatto nella seconda metà del XII secolo, confutando dunque ipotesi passate che addirittura facevano oscillare la sua datazione tra l’VIII e il XIII secolo.
Come molti altri pezzi di ambito arabo, lo scrigno entrò in seguito a far parte dei beni ecclesiastici e forse utilizzato come teca eucaristica o, come alcuni ritengono, come contenitore d’incenso, per la presenza sia ai lati delle staffe sia sul coperchio di piccoli anelli che forse potevano fungere da ganci per catenelle. La sua provenienza è dubbia: secondo una tradizione esso proverrebbe da Canne e giunto a Barletta in occasione del trasferimento nella città delle spoglie di san Ruggiero nel 1276, insieme ad alcuni arredi liturgici. Un’altra tradizione più condivisa fa provenire il cofanetto, insieme ad altri oggetti presenti nel museo della cattedrale, dalla vicina Lucera, la celebre Luceria Saracenorum dove Federico II tra il 1223 e il 1233 confinò gli ultimi Arabi di Sicilia riducendoli all’obbedienza. Qui si diffusero ben presto alcune botteghe artigiane che si occupavano della lavorazione dei metalli preziosi. Nell’agosto del 1300 la presenza araba a Lucera scompare drammaticamente per volontà degli Angioini che ordinarono una spedizione punitiva guidata dal barlettano Giovanni Pipino. Questo personaggio, che tra l’altro fu uno dei promotori dell’ampliamento della cattedrale sotto l’egida angioina, dopo la distruzione e il saccheggio della città, probabilmente portò alcuni di questi pezzi islamici a Barletta come bottino di guerra, facendone dono alla cattedrale.
Descrizione
Autore /Ambito: Manifattura islamica
Datazione: XII-XIII secolo
Materia/Tecnica: bronzo a fusione e lavorato a traforo; aggiunte in ferro
Misure: 10×41 cm; in sospensione 120 cm.
Provenienza: Cattedrale di Santa Maria Maggiore
Descrizione:
La lampada pensile, collegata ad un gancio di sospensione grazie a tre catenelle a maglie intervallate da croci greche, presenta una forma estremamente semplice ma elegante nella fattura. Interessante e di sicuro ambito islamico è la decorazione nella parte concava della lucerna (dove presumibilmente si poneva la lampada in vetro) che presenta un motivo pseudo-epigrafico inciso a traforo, individuato con una serie di grafemi alif lâm, disposti a coppie. Sulla tesa ampia e sottile vi sono tre ganci uncinati che trattengono le catenelle di sospensione; in epoca imprecisata c’è stato un goffo tentativo di risarcire una parte mancante della tesa con un’aggiunta in ferro.
L’utilizzo di motivi pseudo epigrafici è ampiamente diffuso in ambito islamico, come si ritrova ad esempio sul coperchio di uno scrigno d’argento – che presenta due pseudo-iscrizioni cufiche niellate sui lati minori – conservato nel tesoro di san Marco a Venezia e datato XII secolo.
L’uso della scrittura in funzione decorativa è una caratteristica peculiare dell’arte musulmana soprattutto per la valenza evocativa che essa riveste: ogni parola, ogni lettera è emanazione di Dio e come tale, oltre alla sua valenza lessicale, la scrittura riesce a comunicare una suggestione simbolica molto forte. La lucerna in oggetto è associata alla tipologia della gabatha, una lampada con coppa aperta, di cui alcuni esemplari sono conservati nel tesoro di san Marco a Venezia. La lampada veniva utilizzata per illuminare in maniera continua determinati spazi liturgici, come per esempio la zona dell’altare. Questa particolare lucerna è stata negli anni oggetto di diverse interpretazioni rivelatesi spesso bizzarre e prive di fondamento: identificata originariamente dal Ricci come cappello facente parte di una improbabile tomba cardinalizia risalente al XVI secolo, fu in seguito associata ai piombi del rosone della Cattedrale di Bitetto e posta in relazione a Lillus de Barolo, datandola al XIV secolo. Solo con il Toesca si riconosce nell’oggetto una lampada ma con decorazioni di ambito bizantino e collocabile cronologicamente nel XII secolo. Sulla scia di questa interpretazione il Negri – Arnoldi associa il nostro oggetto al modello a polycandeion, confrontandolo in maniera un pò generica a simili esemplari conservati ad Aquisgrana e a Coburgo.
Gli studi successivi hanno evidenziato in maniera decisa, invece, una manifattura islamica, forse realizzata da maestranze operanti in Italia meridionale e databile tra il XII e il XIII secolo. Come lo scrigno conservato in questo museo, anche per la gabata sono state avanzate negli anni diverse ipotesi circa la sua provenienza: mentre appare meno probabile l’arrivo a Barletta di questi oggetti da Canne insieme alle spoglie di san Ruggiero nel 1276, più accreditata è la tradizione secondo cui essi proverrebbero da Lucera. Dopo la distruzione nell’agosto del 1300 della “città dei Saraceni” per ordine angioino, alcuni manufatti islamici sarebbero giunti a Barletta come bottino di guerra e donati alla cattedrale per volontà di Giovanni Pipino, comandante della spedizione e successivamente uno dei principali finanziatori dell’ampliamento gotico della chiesa.
.
Descrizione
Autore /Ambito: Manifattura siculo-araba
Datazione: XII-XIII secolo
Materia/Tecnica: Avorio dipinto, elementi in bronzo
Misure:10×12 cm
Provenienza: Cattedrale di Santa Maria Maggiore
Descrizione:
Il piccolo cofanetto in avorio presenta una forma cilindrica, con decorazioni vegetali e animali stilizzate elegantemente dipinte: si riconoscono pavoni affrontati con colli intrecciati, rapaci che assalgono gazzelle, alberi stilizzati. Le parti in bronzo originarie sono le staffe lanceolate, la cerniera e la serratura mentre le piccole catenelle sono stata aggiunte successivamente in epoca imprecisata forse quando l’oggetto fu utilizzato in ambito ecclesiastico, per poi entrar a far parte del tesoro della cattedrale. Varie sono le ipotesi circa il suo impiego liturgico come, per esempio, l’utilizzo come incensiere, pur mancando tracce di bruciature, o forse più verosimilmente come pisside pensile. Si può, tuttavia, avanzare l’ipotesi di tabernacolo o reliquario pensile, soprattutto considerando le analogie con un altro cofanetto in avorio con coperchio conservato nella chiesa di san Giacomo Maggiore di Barletta, riutilizzato nel XVI secolo come reliquario della lingua di san Bartolomeo. Per la tipologia di oggetto e per le decorazioni di chiara ispirazione araba – più precisamente fatimida e mesopotamica per le decorazioni animali – che ci indicano una sua originaria destinazione profana, il cofanetto si inserisce pienamente nella produzione di manufatti siculo-arabi collocabili tra il XII e il XIII secolo. Numerose le analogie con altri esemplari conservati al Kaiser Friedrich Museum di Berlino, nel Museo germanico di Norimberga, nella cattedrale di Palermo. Per quanto riguarda la sua provenienza, pur non associando il suo arrivo a Barletta con quello dello scrigno e della gabata bronzei legati alla spedizione punitiva di Giovanni Pipino a Lucera, non si esclude, tuttavia, anche per questo cofanetto una provenienza dalla città “dei Saraceni”. Ad avvalorare questa ipotesi sono stati trovati frammenti di avorio presso il palazzo imperiale federiciano, facendo pensare ad una presenza in quel periodo di botteghe artigiane che lavoravano questo prezioso materiale.
Descrizione
Autore /Ambito: Ignoto argentiere di influenza veneziana
Datazione: XIII secolo; rifacimenti XVI secolo
Materia/Tecnica: Metallo, rame e argento con dorature e parti a fusione, cesellato, filigranato, sbalzato, inciso con inseriti castoni con vetri colorati
Provenienza:
Cattedrale di Santa Maria Maggiore
Descrizione:
Secondo il modello della croce patriarcale di Gerusalemme, la stauroteca si presenta a doppia traversa, decorata, nella parte anteriore, da un ricco apparato fitomorfo eseguito con la tecnica della filigrana a intreccio; entro castoni metallici sono applicati vetri colorati di varia sagomatura e dimensione. La lamina di spessore che gira tutt’intorno alla croce è lavorata a sbalzo e disegna un motivo continuo di ramoscello di foglie. La parte posteriore, priva di ornati, reca la ceralacca dello stemma vescovile per l’autentica della reliquia. Fra il XV e il XVI secolo la stauroteca è stata adattata a croce processionale, apportando molte variazioni alla struttura originale; sono infatti stati inseriti diversi nuovi elementi. Tra questi la scena della Crocifissione alla sommità della croce; il Crocifisso, mancante, è posto, secondo l’iconografia bizantina, tra la Vergine e san Giovanni Evangelista e poggia su di un antro in cui è inserito un teschio, a ricordo della sepoltura di Adamo, nella cui bocca fu posto il seme che produsse l’albero da cui fu ricavata la Croce, secondo il racconto della Legenda aurea di Jacopo da Varagine. Ad una fase successiva appartengono anche: le volute a cartoccio poste intorno ai bracci della croce che risultano riposizionate malamente in una fase successiva di smontaggio e rimontaggio; un cartiglio a forma di stemma (forse quello del donatore o solo una semplice decorazione); ed infine la mazza processionale lavorata ad incisione. Scrive G. Boraccesi in “Oreficeria sacra in Puglia tra Medioevo e Rinascimento”: “La parte originaria della stauroteca potrebbe risalire alla seconda metà del XIII secolo, ma rimane più difficile accertare il luogo di produzione: forse proveniente da una bottega veneziana, imbibita di suggestioni bizantine, stando al lavoro di filigrana (opus venetum ad filum) che appunto caratterizza la produzione artigianale di quella città”. Data la presenza accertata in Barletta nel 1277 di “Raffaeli de Venetiis, aurifabro in Barolo commoranti” si può ipotizzare che la realizzazione del manufatto sia dovuta ad una bottega locale, sotto la diretta influenza di maestranze orafe di origine veneziana. Lo storico barlettano S. Santeramo riporta la notizia, in base ad un inventario del 1727, della provenienza della stauroteca dalla chiesa arcivescovile di Nazareth, alla quale sarebbe stata donata dalla “Serenissima Regina Giovanna di Gerusalemme” che lo stesso Santeramo individua essere Giovanna II d’Angiò (1414-1435). S. Di Sciascio in “Reliquie e reliquiari in Puglia fra IX e XV secolo” propone che l’emblema raffigurato nello stemma alla base della croce – tre foglie di vite o di fico volte all’insù – sia quello dell’arcivescovo di Nazareth Bernardino de Figueroa (1553-1571); contro questa interpretazione va tenuto presente che lo stemma dell’arcivescovo de Figueroa è composto da cinque foglie di vite e che il cartiglio posto in basso, sul braccio verticale della croce, è privo di qualsiasi elemento araldico. Luigi Nunzio Dibenedetto.


Descrizione
Autore /Ambito: Ignoto argentiere meridionale
Datazione: prima metà XIII secolo; rifacimenti inizi XVIII secolo (1724)
Materia/Tecnica: rame e argento con dorature e parti a fusione, filigranato, sbalzato, cesellato e inciso con inserzione di castoni con gemme.
Misure: 33×20,5 cm; piede 16,5×9 cm
Provenienza: “A.D. 1724” e “M.o S.a LUCIA BARLETTA”
Provenienza: Monastero di Santa Lucia
Descrizione
Il manufatto mostra una struttura originaria a croce patriarcale a due bracci; l’armatura lignea è rivestita da lamine metalliche decorate con filigrane e inserzioni di pietre preziose. Il recto contiene un frammento del Sacro Legno, inserito in un ricettacolo cruciforme, che ripropone il disegno della doppia traversa. Sia il ricettacolo, che l’intero perimetro della stauroteca, sono sottolineati da una bordura di minute perline. Sulla lamina che fa da spessore della croce, composta da diversi spezzoni metallici, è disegnato un tralcio con foglie che si sviluppa verticalmente. Il pungolo è in rame dorato; attualmente è inserito in un basamento, definendo quindi una croce d’altare, ma si può supporre che la stauroteca potesse essere utilizzata anche come croce astile. Il basamento, con incisa la data del 1724 e la provenienza dal monastero di Santa Lucia, ci fornisce l’indicazione del periodo in cui il reliquiario è stato manomesso, ovverossia “abbellito”. Gli interventi barocchi hanno trasformato la stauroteca, destinata a custodire il solo Sacro Legno, in un reliquiario ed hanno compromesso la lettura dell’opera originaria. L’inserimento di tali nuovi elementi ornamentali sottolinea nel contempo la notevole devozione di cui è stato oggetto il manufatto. Sono stati aggiunti nel XVIII secolo cinque gigli in argento pieno, saldati nelle terminazioni della croce, e la teca ovale al centro della stauroteca, contornata da volute e da fogliami; all’interno sono contenute numerose reliquie con cartiglio. Al di sotto della teca, ai lati della lamina originaria, si notano tracce di ceralacca rossa, palese segno di sigilli apposti da una verifica episcopale. Ricettacoli ovali, contenenti reliquie, sono posti sia sul montante, che sulla traversa maggiore. Dal cartiglio che individua le reliquie si possono ricavare importanti informazioni, in particolare è interessante la scritta: “di san Pio V papa” che costituisce un altro elemento a sostegno della datazione dell’intervento di “abbellimento” sulla stauroteca, poiché il papa sunnominato è stato canonizzato nel 1712, termine post quem per l’apposizione della reliquia stessa. L’applicazione del reliquiario barocco ha celato in parte la struttura del manufatto originario senza, però, cancellare gli ornati medievali arricchiti da una varietà di gemme che decorano gli spazi interni. Alle estremità sono poste delle gemme trattenute da piccole graffe e inserite in finissimi quadrilobi filigranati; ad essi si affiancano quattro castoni rotondi, qualcuno privo di gemma, incorniciati da piccole lamine dal profilo ondulato. Altre filigrane, insieme a castoni gemmati e a piccole sfere, sono saldate sull’intera croce. Nella parte bassa del montante è posto un grosso castone ovale con gemma a cabochon. Il verso, anch’esso compromesso dall’inserzione del reliquiario, è interamente lavorato a sbalzo con un tratto fine nel disegno dei dettagli naturalistici. Questo lato risulta molto interessante dal punto di vista iconografico; intorno all’incrocio della traversa maggiore, nonostante l’apposizione della placca d’argento, sono facilmente riconoscibili i simboli dei quattro evangelisti: sulla stessa traversa il leone di Marco e il toro di Luca, con grandi ali spiegate, nimbati e rivolti verso il centro; sul montante, in alto, l’aquila, simbolo dell’evangelista Giovanni; in basso, sotto l’inserzione barocca, l’angelo, simbolo dell’evangelista Matteo. Alla sommità della croce è raffigurata la Mano di Dio, mentre sulla traversa superiore sono disegnate due mezze figure, una maschile e l’altra femminile, accompagnate da attributi che le caratterizzano, rispettivamente, come il sole e la luna, simboli cosmici che alludono al mistero di salvezza della Crocifissione. Al di sotto di un arco schematicamente sottolineato da un cordone è posta la figura di un personaggio, eretto, atteggiato in posa quasi frontale, con le mani tese verso l’alto, vestito con tunica e mantello e con un copricapo a forma di turbante. L’iconografia è quella di un profeta dell’Antico Testamento, secondo come è usuale venga raffigurato in numerose opere medioevali; in particolare, per l’affinità delle vesti, è stringente il confronto con i profeti scolpiti nella lunetta del portale della Vergine del battistero di Parma, opera di Benedetto Antelami (XIII secolo). Più difficile l’interpretazione di quale profeta si tratti; propenderei per Daniele sia per l’assenza della barba, indice di un’età giovanile, che per la raffigurazione sottostante, che sembrerebbe mostrare ai suoi piedi la testa di un leone entro un antro, a ricordo del racconto biblico del profeta chiuso in una fossa con i leoni. La datazione di questa stauroteca di Barletta potrebbe tranquillamente stabilirsi alla prima metà del XIII secolo, anche se non se ne può avere la certezza, mancando una qualsiasi documentazione a riguardo. Tra le stauroteche medievali presenti in Puglia si mostra come la più ricca di elementi ornamentali. L’autore rende con una cura particolare gli elementi che caratterizzano i personaggi, disegnandoli con un vigore costruttivo, tipico del primo periodo del gotico. Allontanandosi dagli schemi bizantini rende la tridimensionalità delle figure mediante la resa dei movimenti e gli effetti pittorici dati dall’alternanza tra argento e argento dorato. Tali caratteristiche stilistiche risultano affini – in particolare per la figura dell’angelo di san Matteo con le ali aperte all’insù – alla ben conosciuta croce della cattedrale di Veroli, proveniente dall’abbazia cistercense di Casamari e datata al XIII secolo. Confronti più vicini per tempo e per luogo possono istituirsi, per quel che riguarda il recto, con la stauroteca conservata nella cattedrale di Santa Maria Maggiore in Barletta (v. scheda dedicata); per il verso, con quella del monastero di San Ruggiero, sempre in Barletta. Questi paragoni fanno ipotizzare che il manufatto possa essere stato eseguito da un qualificato aurifabbro autoctono o itinerante, anche considerando che fra il XII e il XIV secolo in Barletta sono attestati diversi orefici dimoranti in città e geograficamente diversificati riguardo all’origine.
Luigi Nunzio Dibenedetto
Il circuito dei musei
News ed Eventi

Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Evento 2
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
Basilica Concattedrale Santa Maria Maggiore
P.zza Duomo
76121 – Barletta (BT)
Telefono
Responsabile don Saverio Pellegrino
Tel: 0883 494223
Curia di Barletta
Tel: 0883 531274
Telefono
Concattedrale di Barletta
Tel: 0883 345522
Ufficio Beni Culturali Diocesano
Tel: 0883 494223
Orari e visite
Orari
il Museo è aperto dalle 9.00 alle 12.00 – dalle 17.00 alle 20.00
Il Museo è chiuso:
- Capodanno, Pasqua, 25 aprile
- 1° maggio, 15 agosto, 1° novembre
- 8 dicembre, Natale e S. Stefano
Visite guidate
Su prenotazione, a pagamento, in lingua italiana per gruppi o singoli.
Durata della visita: circa un’ora.
Per informazioni e prenotazioni:
museocattedralebarletta@sistemab.it